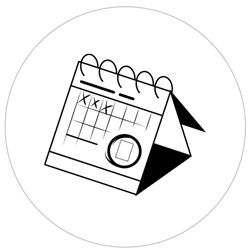Anniversari e Ricorrenze
Nelson Mandela: fuori dal carcere, la libertà di una nazione

Illustrazione di Ana Maria Jucan, 2023, studentessa del Liceo artistico Volta di Pavia. Tecnica mista
Quando finalmente varcai quel cancello per salire a bordo di un’auto dall’altra parte, ebbi la sensazione che nonostante i settantun anni, la mia vita stesse per ricominciare. Mi lasciavo alle spalle diecimila giorni di carcere
Così Nelson Mandela ricorda nella sua autobiografia il momento in cui torna a essere un uomo libero. Sono le 15 dell’11 febbraio 1990 quando si lascia il carcere alle spalle dopo 27 anni di detenzione.
La sostanza di quella lunga battaglia che ha accompagnato gran parte della sua vita e che lo ha condotto in carcere non esaurisce ancora il profilo e il senso del suo impegno pubblico. Infatti, il confronto per il superamento di quella condizione di apartheid verso un patto di convivenza democratica deve ancora trovare una configurazione.
Se l’atto di liberazione è la conditio sine qua non perché si possa dire aperto un percorso, tuttavia da solo quell’atto non sancisce la libertà.
Libertà – Mandela lo dice a sé stesso nel momento in cui supera la soglia del carcere – è essere consapevoli dei propri diritti e avere rispetto di sé.
Non è un principio che connota solo lui e il suo progetto di convivenza. Quel punto non è che una delle tante lezioni su cui l’esercizio del pensiero libero nel corso del ’900, a cominciare da Hannah Arendt, ha insistito con costanza e che ha ripetuto fino all’esaurimento, tanto da apparire imbarazzante.
Del resto, avere rispetto di sé senza che questo si tramuti in sopruso (anche in nome di un’oppressione a lungo patita che chiede riparazione), vuol dire sapere che la libertà è un patto tra diversi. Spesso un patto tra oppositori che convengono su una piattaforma condivisa e che, insieme, si impegnano a rispettare, a mantenere e, nel tempo, a rafforzare.
In questo senso la libertà è un progetto, più che una premessa, che chiede impegno, determinazione e volontà.

Immagine tratta dal libro "La sfida della libertà. Come nasce una democrazia", Feltrinelli, 2018
Tuttavia la lezione riflessiva di Mandela non riguarda solo la fermezza dei propositi e nemmeno un’idea condivisa di potere, o di coabitazione tra diversi che convergono, mutualmente e reciprocamente, su un punto mediano.
Quella riflessione muove dal principio che è conveniente giungere a un compromesso piuttosto che inventarsi un nuovo sistema dove la democrazia è solo simulazione, per tramutarsi in un conflitto irreducibile al termine del quale solo uno degli attori comanda ed è padrone del campo. Qui sta il senso profondo della scena dell’11 febbraio 1990.
Quel passaggio di soglia è un momento essenziale verso la possibilità del nuovo Sudafrica, ma a condizione di non pensarsi in missione per conto di Dio, ovvero caricarsi di un progetto che in forza della propria precedente inferiorità o in relazione alla coltivazione della propria identità negata, proibita, penalizzata o oppressa, sia capace di esprimere libertà per chiunque.
Lo dice poche ore dopo, la sera di quello stesso 11 febbraio 1990, nel suo primo discorso pubblico da uomo libero che tiene a Città del Capo.
Our struggle has reached a decisive moment. We call on our people to seize this moment so that the process towards democracy is rapid and uninterrupted. We have waited too long for our freedom. We can no longer wait. Now is the time to intensify the struggle on all fronts. To relax our efforts now would be a mistake which generations to come will not be able to forgive. The sight of freedom looming on the horizon should encourage us to redouble our efforts.
It is only through disciplined mass action that our victory can be assured. We call on our white compatriots to join us in the shaping of a new South Africa. The freedom movement is a political home for you too. We call on the international community to continue the campaign to isolate the apartheid regime. To lift sanctions now would be to run the risk of aborting the process towards the complete eradication of apartheid.
Our march to freedom is irreversible. We must not allow fear to stand in our way. Universal suffrage on a common voters’ role in a united democratic and non-racial South Africa is the only way to peace and racial harmony.
È questa la lezione che si trae dal passaggio di soglia verso la liberazione e la libertà.
È quella su cui Mandela insiste e che racconta nelle sue memorie ripercorrendo la sua esperienza di detenuto tra anni ’70 e anni ’80, quando lentamente le maglie della sua condizione di prigioniero senza diritti si allargano, e che poi non dimentica una volta tornato libero.
La sua preoccupazione – il suo «chiodo fisso» – è dare forma a un progetto che non sia limitato solo alla «sua gente».
In ogni caso se il conflitto a cui si deve trovare una soluzione è fondato sull’appartenenza (etnica, culturale…), quella soluzione non starà né nella negazione del principio, né nella sua trasformazione in codice eterno.
Sarà, invece, nella sua evoluzione da codice totale capace di dare tutte le risposte, a strumento che può contribuire a individuare dei percorsi. L’appartenenza non va negata ma è una risorsa per le domande di futuro che pone, e non perché è un «porto sicuro» in un tempo di «mare in tempesta».
In altre parole: l’identità è uno strumento, non un cibo precotto. Serve a fare e a farsi domande, non serve se è un farmaco e, ancor meno, se è una terapia.
Quella strada, che già allora appariva in controtendenza – per alcuni perfino incomprensibile – rispetto al fascino che il codice fondamentalista esercitava sui molti che dicevano di praticare le strade di uscita dall’oppressione subita, continua a essere difficile e complessa.
Anche ora, nel nostro tempo presente.
La libertà, pagina dopo pagina
Gli altri approfondimenti

La posta della redazione
Hai domande, dubbi, proposte? Vuoi uno spiegone? Scrivi alla redazione!
Conosci l'autore
Per poter aggiungere un prodotto al carrello devi essere loggato con un profilo Feltrinelli.
Per poter aggiungere un prodotto alla lista dei desideri devi essere loggato con un profilo Feltrinelli.
Il Prodotto è stato aggiunto al carrello correttamente
Il Prodotto è stato aggiunto alla WishList correttamente