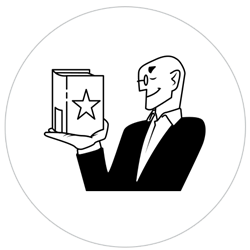Scelti per voi
Giorni Selvaggi di William Finnegan
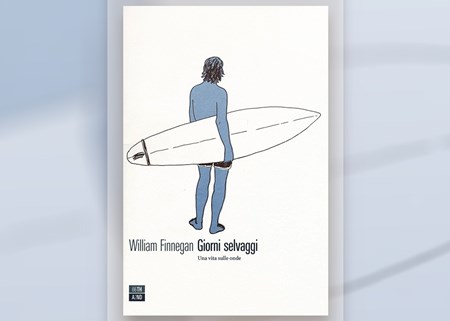
Il surf non porta da nessuna parte, almeno in apparenza. Stai seduto a cavalcioni in mezzo all’oceano e aspetti l’onda, a volte anche per ore. Appena ne vedi una montare all’orizzonte giri la tavola e cominci a remare. Quando l’onda si solleva ti alzi in piedi, prendi la traiettoria, e finalmente cavalchi – più o meno bene – la sua parete per una manciata di secondi.
Torni indietro, e ripeti daccapo.
A fine giornata sei esattamente dove eri prima, solo più stanco, cotto dal sole, e con le mani e i piedi tagliuzzati nel migliore dei casi.
Eppure gli indigeni polinesiani cavalcano le onde da un tempo così lontano che non ha memorie, e quando il capitano Cook sbarcò a Tonga, rimase talmente affascinato che scrisse dei progenitori del surf nei propri diari.
C’era un incanto misterioso in quelle sagome in controluce che danzavano mute nel bagliore accecante del tramonto, le tavole simili a enormi lame scure che fendevano l’acqua e planavano veloci sotto i loro piedi.
Anche il piccolo William Finnegan viene rapito dall’incanto della tavola.
A me, con i miei dieci anni, quelle onde che s’infrangevano sopra un letto di roccia sembravano arrivare da un’officina celeste, le creste fosforescenti e le pareti sottili intarsiate dagli angeli dell’oceano. Volevo essere là fuori, e imparare a danzare sull’acqua.
La famiglia di William si trasferisce alle Hawaii, e per un aspirante surfista non c’è terreno più ideale. Così il primo incanto si trasforma presto in ossessione adolescenziale, traboccante di un desiderio insaziabile e di una disciplinata dedizione.
Nella crescita da ragazzetto magrolino a giovane uomo, l’agonismo famelico lascia posto a un nuovo ideale che stava prendendo piede, quello della solitudine, della purezza, delle onde perfette in un mondo incontaminato.
Il William ventenne decide allora d’imbarcarsi in un viaggio intorno al mondo all’inseguimento delle onde, in un periodo storico dove gli unici canali d’informazione sono la posta e il passaparola. Questo atto di puritana ribellione lo intraprende con Bryan, il figlio della classe operaia che è stato al funerale di Kerouac. Insieme cavalcano le onde di Guam, delle isole Samoa, di Tonga, delle Fiji e del Sudafrica; onde destre e sinistre, basse e double-overhead, ripide e lunghe, torbide e trasparenti, blu, turchesi, grigie.
Poi l’incanto si rompe. Quella poetica ricerca di colpo appare a William come un errare insensato, e torna in America.
Si stabilisce a San Francisco e diventa un editorialista e reporter di guerra, ma non appende la tavola al chiodo. Spinto dal fanatico e chiassoso Mark, e in compagnia del taciturno Pewee, – che a una tavola fa fare qualsiasi cosa – William si accosta al big-waves surfing dove l’oceano diventa un’enorme bocca in cui farsi inghiottire è un atto di fede spesso sconsiderato, un territorio selvaggio e ostile, una realtà indifferente e dinamica, (…) un Dio insensibile, infinito nella sua pericolosità, dotato di un potere smisurato.
Poi finisce anche questa elettrizzante ricerca del limite. William si trasferisce a New York con la moglie e la figlia, ma anche quando compie sessantaquattro anni, e il suo corpo non scatta e non resiste più come prima, passa i suoi inverni sulle onde di Madeira. Non può più smettere di surfare.
Giorni selvaggi (66thand2nd) è il diario di una vita, e ci sono pagine di famiglia, crescita, amicizie, violenza, amori, silenzi, viaggi, miseria e scrittura, ma la chiave di volta resta sempre il surf. Perché per lo scrittore surfare è molto di più che fare l’equilibrista dell’oceano.
I surfisti sono ossessionati dalla perfezione. L’onda perfetta e via discorrendo. Tutta roba che non esiste. Le onde non sono oggetti naturali immobili come le rose o i diamanti. Sono eventi rapidi e brutali al termine di una lunga catena di azioni tempestose e reazioni oceaniche
Per Finnegan il surf non è uno sport, è un sentiero. E la ricerca dell’onda è un gesto per toccare i propri limiti e tastare il proprio posto nel mondo.
Anche la sua scrittura è come un’onda, che scava nei fondali profondi con pazienza per poi sprigionare tutta la sua potenza e bellezza quando si tratta di descrivere il terribile splendore del surf.
La lingua di questo libro è una lingua che parla il gergo dei surfisti, è una marea effervescente di parole come swell, breakpoint, spot e goofyfoot, ma è una lingua che anche nei termini più tecnici non perde mai la sua umanità.
E arrivando all’ultima pagina di questo memoir, al lettore è perfettamente chiaro come fa una tavola stesa su un’onda a condizionare in modo così viscerale la vita di una persona.
Le recensioni della settimana

La posta della redazione
Hai domande, dubbi, proposte? Vuoi uno spiegone? Scrivi alla redazione!
Conosci l'autore
Per poter aggiungere un prodotto al carrello devi essere loggato con un profilo Feltrinelli.
Per poter aggiungere un prodotto alla lista dei desideri devi essere loggato con un profilo Feltrinelli.
Il Prodotto è stato aggiunto al carrello correttamente
Il Prodotto è stato aggiunto alla WishList correttamente