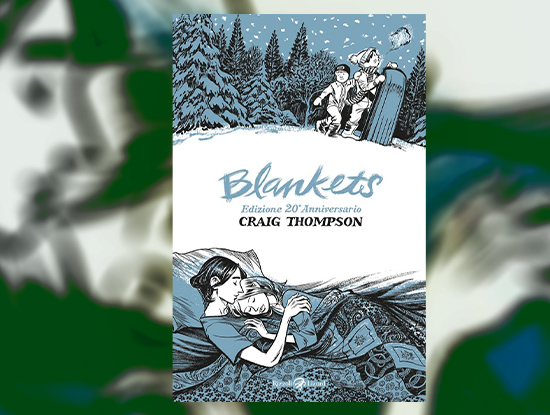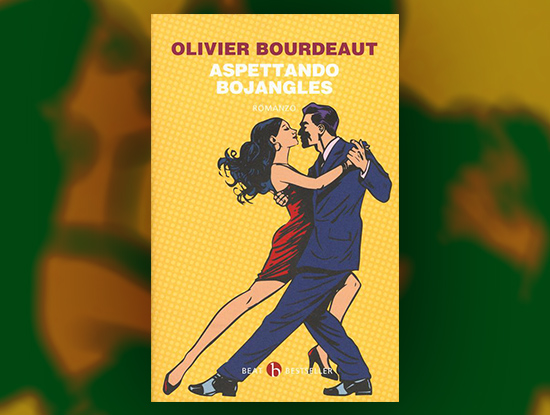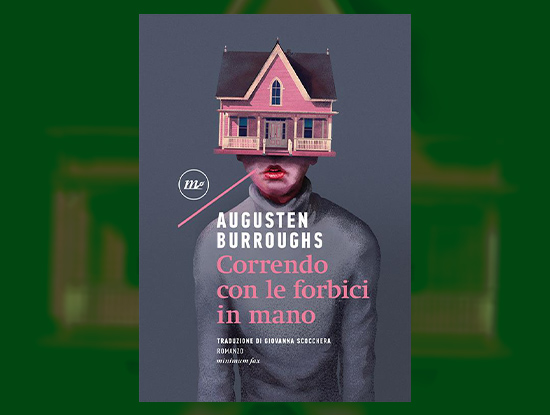Strade di carta
Libri e ricordi d'infanzia

Illustrazione digitale di Gaetano Di Riso, 2021
L’infanzia è il sale della terra. Perda il proprio sapore e il mondo sarà in poco tempo solo putrefazione e cancrena
Chiunque sia sopravvissuto alla propria infanzia possiede abbastanza informazioni sulla vita da bastargli per il resto dei suoi giorni
Si scrutano a distanza queste due sentenze. Dirimpettaie, forse, ma con un cratere di mondi intermedi da attraversare. Appartengono entrambe a due scrittori, e ne riverberano ferocemente il punto di vista, la singolarità di chi vive scegliendo di raccontare.
La prima è di George Bernanos, autore in letargo, come spesso da libraia definisco quelli sempre meno richiesti dai nostri lettori e dissepolti di rado da qualche intrepida adozione scolastica.
L’altra è diretta emanazione di Flannery O’Connor, strepitosa lancinante autrice americana, non abbastanza letta, ma pazzamente amata da chi riesce a incontrarla.
Tutti e due, fin da piccoli farciti a forza di fervore cattolico, partoriscono in questi pensieri due esiti diametralmente opposti. Salvifico nel primo caso, fatale nel secondo. Come se, almeno per O’Connor, mirare troppo al cielo lo facesse schiantare su chi guarda.
Comunque ci si possa esprimere, l’infanzia resta lì, a torreggiare su di noi, come fortezza del ritorno impossibile o monumento alle occasioni sfiorite.
Esulando da pareri più nobili, ma scortata da infinite altre voci, sono convinta che tutto il potenziale di un buon uomo adulto si agiti lì, nei suoi primi anni, in quell’antro di ovatta e di latte che lo nutre al di là della bocca. Il primordiale tratto di strada in cui l’amore della mano che ti guida inizia a comporre la tua vera storia.
La narrativa che ho sempre consumato, proprio così avidamente come si fa con il cibo, gronda di bambini alle prese con la sfida di farsi grandi, di impadronirsi dello spazio senza dimenticare di farsene stupire, di non sfatarsi al punto da calpestare i germogli sul sentiero.
Ma cosa accade quando mentre lo fanno nessuno li abbraccia?
Di cosa sanno le infanzie sgualcite, che qualcuno più tecnicamente etichetterebbe come “disfunzionali”?
Come si cresce quando intorno c’è sempre qualcosa o qualcuno di più importante del tuo essere minuscolo?
A saperlo benissimo, ferendoci in pieno ad ogni risposta, c’è Paulette, protagonista del romanzo di François Boyer, Giochi proibiti (Adelphi).
Il suo è un mondo falcidiato dalla guerra, dove l’orrore grida più forte, dove nei paraggi non esiste carezza o riparo a forma di madre. I bombardamenti l’hanno privata dei genitori e a Paulette non rimane che il suo berretto calato sugli occhi e Michel, il suo migliore amico, con cui affronta la polvere di ogni giorno infelice.
Paulette a nove anni conosce a dovere le sfumature del sangue, da quello rosa a quello sporco e azzurrognolo in cui si imbatte cercando i piedi del padre. È una vita perennemente scalza, dove crescere punge e non chiede scusa.
La bambina è quasi affascinata da questo costante senso di morte che le aleggia intorno, così familiare da sembrarle un parente. Vaga tra fantasmi che prima erano uomini, ingolla l’asprezza della sua terra, dove nessuno si accorge di lei. Scava fosse per gioco, perché chi l’ha generata non è stato sotterrato e dichiara assieme a Michel che anche un’ape merita una croce.
La testa di Paulette è una burrasca di fogliame, croste di affetti essiccati, impronte di scarpe che non rivedrà.
Nel flusso dei suoi pensieri ci fu un vuoto, una specie di tempo morto, mentre una foschia indistinta copriva il fermento confuso del suo subconscio. E di colpo il subconscio schizzò fuori con violenza (…) C’erano soprattutto cavalli e cani, cani, cani – cani vivi, cani feriti, cani morti
Il potere di un romanzo è spesso, come in questo caso, quello di risvegliare immagini, di tracciarci davanti il paesaggio di quegli umori, le ombre che annegano intorno ai destini.
Blankets di Craig Thompson (Rizzoli) è un esempio folgorante di come la narrazione sappia anche invertire il processo e far gemmare parole da una sequenza di segni.
La vicenda è quella dell’autore, la sua de-formazione in Wisconsin, l’amarezza impietosa che lo ha educato, costringendolo a condividere un letto strettissimo con suo fratello, quando non ad accasciarsi in uno stanzino infestato di topi e di chiodi. Di assi divelte e mille sussulti. Un padre-castigo, che lo umilia e lo ingiuria senza appello, vacanze nefaste confinate in campi ultrareligiosi per ragazzi sgangherati, dove impazzano il buio e la sopraffazione. Notti di freddo e di afa che sanno di contrappasso dantesco, avvolto dall’umida certezza che nessuno lo avrebbe protetto.
Il risultato è un silenzio di tavole mute che spacca gli occhi e inonda il cuore. Un passato di pietra che si scheggia soltanto quando Craig potrà innamorarsi e assaggiare finalmente la dolcezza di un volto.
Ma non è unicamente la solitudine a solcare dirupi. Avere qualcuno da chiamare “mamma” non rappresenta di per sé nessun lieto fine. Ci sono madri che non nascono mai. Che ospitano un battito di troppo a cui non si abituano. Madri incastellate in quello che furono e incapaci di viversi in un altrove di pianti e di insonnia.
Madri dentro una bolla, sempre intoccabili malgrado siano proprio a due passi, madri pesanti quanto un’assenza che ricamano orbite inconfessabili.
Aspettando Bojangles di Olivier Bourdeaut (Neri Pozza) ci immerge in un pianeta dove a dominare è una donna che cambia continuamente nome, perché suo marito la battezza ogni giorno in modo diverso, una donna che adora ballare sulle note di Nina Simone e accantonare ogni bruttura del mondo.
Suo figlio descrive questa madre fiabesca, che ondeggia e sorride e inventa ennesime nuove esistenze per scongiurare la propria. Perché la realtà, spesso, ha un suono troppo aspro per volerlo pronunciare.
Non mi trattava né da adulto né da bambino, ma piuttosto come un personaggio da romanzo. Un romanzo che lei amava molto e teneramente, nel quale si immergeva ogni istante
La leggerezza quasi ipnotica di Bourdeaut si libra intorno a questa famiglia sui generis a ritmo di danza e anche l’innominabile sa farsi magico.
Ognuno di questi protagonisti cercherà il suo modo di essere bambino.
Bambino nonostante, bambino attraverso le infinite foreste di legami e d-istruzioni impartite dagli adulti.
Anche Augusten Burroughs non può raccontare un’infanzia canonica, imbottite di cure e gesti in cotone.
A nove anni per lui è normale simulare il suicidio per scampare alla scuola, è normale sapere che non può fidarsi, che lo psichiatra da cui è in affidamento è molto più folle dei suoi pazienti, che suo padre alcolizzato e sua madre trasognata sono da tenere a bada. E il suo tempo è una sfida, ingoiando il vento, Correndo con le forbici in mano (minimum fax). Un memoir rocambolesco e turbato in cui tutti i presunti scontati equilibri necessari per diventare grandi scricchiolano come ossa fragili e la purezza è una preda di tutti gli incontri.
Incredibile affrontare le sue riflessioni col nostro filtro di genitori ossessivi, perennemente arpionati dall’ansia di sbagliare, di non fare abbastanza mentre sommergiamo i nostri figli di accudimenti iperbolici che fanno bene solo a noi. Augusten ha ben altri bisogni:
…c’è uno strano senso di appagamento a tagliarsi e sanguinare. Una di quelle giornate grigie quando le otto di mattina non sembrano diverse da mezzogiorno, quando non è successo niente e niente succederà, quando stai lavando un bicchiere nel lavello e il vetro si rompe e – accidentalmente – ti incide la pelle. E ora c’è questo rosso scioccante, la cosa più luminosa della giornata, sgorga così intenso, il tuo sangue, che sembra vibrare…A volte non è male che succeda, almeno sai di essere vivo
Si cresce, quindi, rammendando i burroni, aggiustando le mancanze come si fa con i vasi sbeccati, con le bambole scucite.
Si cresce come fa Lorenzo, protagonista del romanzo di Andrea Bajani, Se consideri le colpe (Feltrinelli).
Lorenzo ha una mamma che lavora tanto, che lavora e parte, parte sempre più spesso.
Parte tanto che torna sempre più tardi. E poi non torna più. La Romania dopo il crollo del regime sovietico è diventata un altro Paese e l’ha assorbita come un enorme stomaco.
E Lorenzo resta bambino senza di lei, fin quando, dopo anni, la madre muore e lui si affaccia in quei luoghi che le appartennero durante la separazione, per tentare di riannodare i lembi di quel rapporto sospeso, dove è colata rabbia e fame impaziente:
È così che ho cominciato a non volerti sentire più al telefono e quando suonava di sera facevamo di tutto per non tornare in tempo. Le telefonate mensili sono diventate semestrali e poi soltanto per gli auguri di Natale. E così io e papà, che fino ad allora non sapevamo che farcene l’uno dell’altro, ci siamo ritrovati complici di qualcosa che aveva a che fare col disprezzo di te
Sono anche questi i mille nodi dell’infanzia. Molti dei quali nati per non sciogliersi.
Dai frantumi che resistono emerge il ritaglio di ciò che saremo, la scommessa incessante di trascenderci senza poterci scordare, di rispondere a ciò che sarà col desiderio invincibile di leggere nuovi inizi e scrivere altri finali.
I libri consentanei di Cristiana Saporito
Le altre strade di carta

La posta della redazione
Hai domande, dubbi, proposte? Vuoi uno spiegone? Scrivi alla redazione!
Per poter aggiungere un prodotto al carrello devi essere loggato con un profilo Feltrinelli.
Per poter aggiungere un prodotto alla lista dei desideri devi essere loggato con un profilo Feltrinelli.
Il Prodotto è stato aggiunto al carrello correttamente
Il Prodotto è stato aggiunto alla WishList correttamente