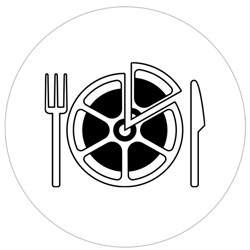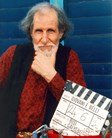Sapore di sala
Roberto Benigni, 70 anni straordinari

Compie settant’anni quel corpo rivoluzionario, quel corpo magro, con gli occhiali e i capelli scapigliati in testa.
Roberto Benigni, a volte, ricorda un po’ Woody Allen e, come Woody Allen, è puro e violento al tempo stesso, è imprevedibile, è un genio della parola, e ci fa anche ridere.
Ci ha regalato risate fin da quando noi – più anziani – lo vedemmo spuntare da una tv in bianco e nero, a metà degli anni ’70.
Era una trasmissione inverosimile, impossibile: ambientata in una stalla, con tanto di paglia e di mucche. E lì in mezzo c’era Benigni. La trasmissione si chiamava Onda libera: avrebbe dovuto chiamarsi Televacca, ma poi qualcuno ebbe paura. Ma pur con un titolo più rassicurante, quella era chiaramente una televisione eversiva, era la vera rivoluzione che hanno conosciuto i bambini cresciuti negli anni ’70. Fra gli ospiti, ci fu anche Francesco Guccini: insieme si misero a improvvisare in ottava rima, come si faceva da secoli nelle campagne toscane ed emiliane.
Fecero a gara, a improvvisare rime sempre più bizzarre, strampalate, sempre più belle.

Odorava di campagna, Roberto Benigni e, nonostante tutto, quel magnifico odore di terra e di campo non gli è mai andato via.
Nelle sue parole, anche adesso che in TV racconta Dante, la Costituzione e i Dieci comandamenti, anche adesso che ha scoperto la Madonna e Dio, le sue parole sono sempre legate alla terra: l’olio, i cocomeri, le albicocche, l’aceto, il sale. Sono parole che Benigni usa più spesso di “resiliente” o di “distopico”. O di “metaverso”.
Eppure, quante volte Benigni ci ha portato in universi distopici e in metaversi meravigliosi!
Accompagnandoci ad esempio nel Millequattrocento, quasi Millecinque di Frittole, in quel Rinascimento ruspante e paesano, dove Massimo Troisi e Benigni infilavano i loro corpi così diversi, le loro comicità così diverse: i mezzi gesti, le mezze parole di Troisi, la sua prudenza, la sua infinita malinconia; e l’esuberanza di Benigni, il suo interagire continuo con tutto e con tutti.
Quando camminano insieme, in Non ci resta che piangere, sono bellissimi. Non soltanto nella scena celeberrima della lettera al Savonarola.

Benigni è stato ed è un corpo imprevedibile, insomma.
Capace di passare dal cinema di Marco Ferreri a quello di Bernardo Bertolucci, capace di prendersi in collo Enrico Berlinguer a una festa dell’Unità, in quella foto diventata più virale di ogni video virale degli anni Duemila. Capace di bestemmiare per dieci minuti, nel film Berlinguer ti voglio bene, in una litania di imprecazioni feroci e mai sentite prima, riuscendo a non essere blasfemo, perché si rivolgeva a un Dio che forse non c’è, che aveva permesso la morte di sua madre; era un grido di dolore, un «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?»
C’era del sacro in quelle parole feroci, pronunciate camminando in un campo, seguito da una carrellata che sembrava non finire mai.
Un corpo capace di impadronirsi di un film di Jim Jarmusch, di farlo diventare suo, di oscurare talenti e personalità come quelle di Tom Waits e di John Lurie, i due protagonisti americani di Daunbailò: per i primi venti minuti di film, c’è un’opera di Jarmusch, con attori di Jarmusch. Poi arriva Benigni, e non è più lo stesso film.
Nel mondo dello spettacolo italiano, da quando arriva Benigni non è più lo stesso film.
Quando Benigni ha vent’anni, è l’alba degli anni settanta, la creatività sembra davvero vivere una stagione incredibile, fertile, meravigliosa: sembra di poter dire tutto.
Dalle canzoni di Enzo Jannacci ai personaggi di Paolo Villaggio, da Cochi e Renato ai Delirium che s’impadronivano del palco di Sanremo con le loro camicione e i capelli lunghi, echi nostrani di Woodstock. C’era libertà, c’era un vento nuovo. Ma nessuno ha portato una tempesta di nuovo quanto Roberto Benigni.
Renzo Arbore se ne accorge, lo chiama all’Altra domenica, la prima grande trasmissione di successo del secondo canale Rai: lui interpreta un critico cinematografico sgangherato e folle.
Poi arriva tutto il resto. «Berlinguer ti voglio bene», lui che porta sulla canna della bicicletta Carlo Monni, gigante e amico, il suo Obelix personale, vichingo pieno di vento nato a Champs-sur-le-Bisance, che per noi mortali è Campi Bisenzio.

Poi arriverà tutto il resto: il bacio a Olimpia Carlisi sul palco di Sanremo, Benigni che – qualche anno dopo – si scatena inseguendo per tutto il palco Raffaella Carrà, alla ricerca della sua “patonzina”, con la Carrà sorpresa per davvero, come mezza Italia. Ci saranno le serate del premio Tenco, Benigni che suona la chitarra, che entra nel salotto buono della cultura italiana, fra la musica d’autore e il cinema d’autore.
Ci sarà quel film unico nella storia del cinema italiano: quello con cui Federico Fellini abbraccia la forza eversiva di Roberto Benigni e di Paolo Villaggio, ne La voce della Luna.
Entrambi saranno troppo intimoriti, troppo irretiti dalla personalità del Maestro per scatenarsi davvero: e al film manca qualcosa, manca la verve di quei due mattatori.
Nasce un film irrigidito, freddo e astratto. È un incontro che avrebbe potuto donare altro: il rispetto reciproco forse, in quel caso, non ha permesso l’esplosione dell’arte sporca, libera e surreale di tutti e tre. Ma pochi anni dopo, quando Fellini muore, Benigni improvvisa una poesia che vale tutto quel film: «Quel giorno, dimmi chi non lacrimava / nemmeno la persona la più frigida / pianse Rondi co’ Akira Kurosawa / pianse la Loren con la Lollobrigida. Era leggero come Cavalcanti / saggio come i filosofi tedeschi / umano come sanno esserlo i santi / profondo come Fjodor Dostoevskij».
E ce ne vuole, fra parentesi, di bravura, per fare una rima con Dostoevskij.
«Dolce come Verlaine, come Beatrice / e maledetto come James Dean / casto della purezza d’Euridice / intelligente come Rin-tin-tin». Anche fare una rima con Rin-tin-tin non è cosa da poco.

Anni ’90: Benigni che incontra Vincenzo Cerami, ruvido e poetico scrittore, ex studente di una scuola media a Ciampino, dove insegnante di Lettere era un giovane Pier Paolo Pasolini.
Insieme a Cerami, Benigni costruisce i successi dei suoi film che ogni volta – ora ce lo siamo dimenticati, quasi – frantumano i record di incassi: Il piccolo diavolo, Johnny Stecchino, Il mostro, fino ad arrivare a La vita è bella.
Se lo guardi nella costruzione, nel realismo, nei costumi, nelle scenografie, non diresti che è un film perfetto. Non lo è, no.
Ma ha un’idea talmente forte, talmente vincente, che travolge tutto il resto. L’idea di un padre che, di fronte alla propria morte, di fronte all’abisso in cui sta finendo l’umanità, ma di fronte agli occhi del figlio che lo guarda, compia l’ultimo sacrificio: sorridere, fargli credere che sia tutto uno scherzo, inventarsi mille stratagemmi per non far capire a un bambino che in fondo a tutto c’è la morte. Dirgli che va tutto bene, che alla fine si vince un carrarmato di cioccolata. In fondo è il più grande sacrificio che compie, ogni giorno, l’attore, l’artista: cercare di non farci pensare alla fine del viaggio, alla fine che ci aspetta tutti. Farci vedere i carrarmati di cioccolata.
Benigni, in quel film, disegna una metafora dell’artista. Che disegna meraviglie per gli occhi del bambino, che siamo noi, noi spettatori. Che poi, alla fine, arrivino gli americani a liberare il campo, invece dei russi, a me importa poco. Nella nostra esperienza di italiani, gli Alleati che ci hanno portato la fine della guerra erano americani: quello, probabilmente, ha immaginato Benigni. Ma non è lì il centro di quel film. Il centro di quel film è nell’impegno straordinario di farci sorridere nonostante la sofferenza. Il sacrificio dell’artista, quello per cui gli siamo grati.
Poi è venuta la corsa sulle sedie del Kodak Theatre, sopra la testa di uno Spielberg allibito, tra gli applausi di tutti, Oscar per il miglior film internazionale e Oscar per la migliore interpretazione maschile, riconoscimento mai andato prima a un attore italiano. E lui che, nel ringraziare, dedica le parole più preziose alla moglie, Nicoletta Braschi, e alla madre Isolina e al padre Luigi: «Vi ringrazio per avermi dato il dono più grande, la povertà». Erano contadini, nati all’indomani della Prima guerra mondiale. Se ne sono andati nello stesso anno, il 2004.
Hanno fatto in tempo a vedere quel loro figlio vincere il più importante premio mondiale per un cineasta. Li vidi, alla “prima” del film, a Firenze, quando ancora La vita è bella doveva cominciare tutto il suo cammino. Erano minuscoli, impacciati, di sicuro intimiditi da tanta gente. Chissà come si sono sentiti, all’applauso finale.
Dopo quel successo, era difficile mantenere lo standard promesso.
È persino normale che Benigni fosse disorientato: «Continuano a mandarmi copioni in inglese perché pensano che io li capisca, ma non è mica vero. Poi gli telefono, gli invento delle cose, very good, but now I’m busy». E così la possibile carriera americana non inizia. E lui sceglie, per proseguire, la più toscana e più universale delle storie: quella di Pinocchio.
E lì sbaglia i conti, ritagliandosi il personaggio di Pinocchio: a cinquant’anni, anche se hai un’anima di fanciullo, è difficile far credere al pubblico di tutto il mondo che tu sei un burattino che è anche un bambino. Riuscirà a commuovere, a toccarci l’anima quando – in un altro Pinocchio, quello di Matteo Garrone – interpreterà un Geppetto malinconico e dolente.
Ma il cinema non è facile da fare. Non è facile da calcolare. «Il cinema non è come il mare, è come il cocomero. Finché non si apre non si sa se è buono o no. Quando tu giri una scena puoi dire: mi sembra buona! Quando il cocomero è chiuso, dal suono dici: forse è buono! Ma poi quando l’apri è come il cinema quando lo vedi sviluppato. Al suono sembrava buono, poi magari…»

Gli ultimi dieci anni, per Benigni, sono quelli in cui ha raccontato Dante e la Divina Commedia, recitandola, commentandola, nelle università, nelle piazze e infine in televisione.
Poi ha raccontato la storia dell’Unità d’Italia, ha dedicato uno show alla Costituzione italiana. Da rivoluzionario a istituzionale: un cammino forse impensabile.
Dalla poesia in ottava rima, improvvisata e ruspante, alle terzine dantesche; dalle imprecazioni ai Dieci comandamenti, che racconta in tv nel 2014 davanti a dieci milioni di spettatori.
Dal fuoco all’acqua santa. Che cosa c’è in comune, dov’è la continuità fra i due Benigni, quello che diceva «Woitylaccio» a papa Wojtyla e quello che riceve la telefonata di papa Francesco, dopo che ha raccontato in tv i dieci comandamenti?
Ma in fondo, forse non c’è distanza, forse non c’è contraddizione.
Benigni ha sempre cercato l’assoluto, è stato un puro anche quando era sboccato, greve, “volgare” – e invece non lo era – e prendeva in giro gli attributi sessuali dei politici, da Andreotti a Berlusconi. Già in Berlinguer ti voglio bene cercava una vita che fosse poetica, rivoluzionaria, straordinaria. E continua a cercarla ora, continua a cercarla esplorando senza stancarsi alcuni dei testi più grandi, più entusiasmanti che l’umanità abbia prodotto: il viaggio di Dante nell’umanità e nei misteri dell’aldilà, lo sforzo di un paese intero di scrivere il “disegno” di un’Italia nuova nella Costituzione del 1948, e infine lo sforzo dell’uomo di immaginare Dio, di sfiorare Dio, di entrare in contatto con lui, attraverso le parole della Bibbia.
L’anno scorso, il Leone d’oro alla carriera a Venezia. Offerto alla donna della sua vita, Nicoletta Braschi.
A cui dedica il premio, assieme a una frase meravigliosa di Jorge Luis Borges: «Conosco una sola misura del tempo: con te o senza di te».
La poesia dice, pochi versi prima: «A cosa mi serviranno i miei talismani, l’esercizio delle lettere, la vaga erudizione, le gallerie della Biblioteca, le cose comuni, il sapore del sonno? Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo». E da quando si sono incontrati, negli anni ’80, per poi sposarsi nel 1991, per Benigni Nicoletta sembra davvero la misura di tutte le cose, l’inizio e la fine dell’orizzonte, in un amore che ha il sapore antico dell’assoluto.
Benigni ha sempre cercato l’assoluto, ha sempre cercato la bellezza.
È l’ultimo erede di un’Italia contadina, antica, è il figlio di mamma Isolina che catturava i conigli – un monologo memorabile di Daunbailò su «my mother Isolina», dovete ritrovarlo per ridere come pazzi. È un uomo magro con gli occhiali, che quando non è Roberto Benigni ha la voce bassa e mite, ma quando c’è un pubblico torna a saltare e a far squillare la voce, come il padre del film La vita è bella, quando sa di essere guardato dal piccolo Giorgio Cantarini.
Ti potrebbero interessare

La posta della redazione
Hai domande, dubbi, proposte? Vuoi uno spiegone? Scrivi alla redazione!
Per poter aggiungere un prodotto al carrello devi essere loggato con un profilo Feltrinelli.
Per poter aggiungere un prodotto alla lista dei desideri devi essere loggato con un profilo Feltrinelli.
Il Prodotto è stato aggiunto al carrello correttamente
Il Prodotto è stato aggiunto alla WishList correttamente