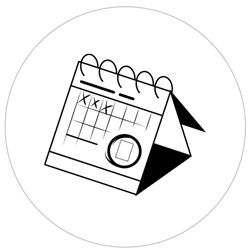Anniversari e ricorrenze
I libri del 1952: romanzi e racconti

Illustrazione di Francesca Mugni, 2022, studentessa del Liceo Artistico A. Volta di Pavia
«Ma nessuno ha sottolineato che il web stesso è un miracolo.»
Gli splendidi sette settantenni: cosa si leggeva in Italia nei primi anni Cinquanta?
Ci sono annate buone e meno buone. In tutto. Il sole che matura l’uva e dona al vino una corposità, un aroma straordinario, le piogge che al momento giusto irrigano i terreni per un raccolto fruttuoso, il clima culturale che genera capolavori musicali tutti insieme, tutti datati – ad esempio – 1967. Una folata creativa che attraversa città, regioni e nazioni e che ha generato nel 1952 un numero incredibile di libri da ricordare.
Son passati settant’anni ma restano lì, nei nostri scaffali. In alcuni casi aprendo le pagine urlano ancora con tutta la loro forza dirompente. Altre volte no, non sembrano scritti ieri e un po’ il passare del tempo li sbiadisce, rende il tono della loro voce più flebile, ma sono ancora qui, sono ancora acquistati e letti e le nuove generazioni hanno ancora voglia di scoprirli. Non è poco.
Ne ricordiamo alcuni con i primi commenti della critica “a caldo”, quando vennero pubblicati o poco dopo - perché nulla racconta meglio un libro delle parole dei contemporanei -, o con estratti di recensioni più recenti, per cogliere il senso della loro attualità.
La tela di Carlotta di Elwyn Brooks White
Pubblicato nel 1952 con le illustrazioni di Garth Williams Charlotte’s Web è un classico per bambini che sembra immortale. In Italia arrivò nel 1959 pubblicato da Vallecchi nella traduzione autorizzata di Isabella Errico e Donatella Ziliotto, successivamente ripubblicato da Mondadori in una nuova traduzione della Ziliotto con Isabella Fanti e illustrato da Adelchi Galloni.
A proposito del suo romanzo lo stesso Elwyn White scrisse, in una sintesi perfetta delle ragioni di questo successo:
«La tela di Carlotta è una storia di amicizia, vita, morte e salvezza.»
Un libro sull’inclusività, la responsabilità, sulla gioia e sul dolore. Un libro sulla vita e sul senso dell’amicizia.
L'amicizia tra Charlotte (la ragnetta) e Wilbur (il maialino), nonostante le loro differenze di natura, insegna la tolleranza. Pur affrontando il dramma della morte, è anche un testo pieno di umorismo, con personaggi ironici come le oche e le pecore snob. Ricordiamo che E.B. White era un collaboratore fisso del New Yorker dove scriveva arguti pezzi sulla società contemporanea cogliendone gli aspetti più divertenti.
André Bernard in Madame Bovary c’est moi (Sperling & Kupfer 2004) commenta: «La sua creatura, una ragnetta bruna che insegna al maiale Wilbur il senso della vita, è diventata una delle figure più amate di tutta la letteratura per l’infanzia. White trovò l’ispirazione sul terreno della sua casa di Brooklin, nel Maine, dove si era trasferito nel 1928, l’ambiente ideale per scrivere e condurre una vita tranquilla, in cui dedicarsi anche all’allevamento: aveva infatti qualche pecora, alcune oche e un maialino di nome Wilbur. Dopo un po’ lo scrittore si accorse che al gruppetto si erano uniti di nascosto un vecchio topo e un ragno. Osservò la ragnetta per circa un anno mentre era intenta a tessere la tela, catturare mosche e deporre uova. Chiamò il vivace animaletto Carlotta per la sua meticolosa e disciplinata aria alla New England, e presto ne fece la protagonista del libro. Al suo editore disse che la ragnetta non sarebbe piaciuta ai lettori in cerca di una versione disneyana degli animali: in natura la vita è dura, gli animali si mangiano tra loro e muoiono proprio come succede a Carlotta.»
E invece piacque, e tanto. Anche se non fu la Disney a farne il primo film d’animazione, ma Hanna-Barbera nel 1973.
Il visconte dimezzato di Italo Calvino
Ecco un meraviglioso classico italiano. Si è detto e scritto tutto su questo romanzo e sugli altri due che compongono la trilogia I nostri antenati: Il barone rampante (1957) e Il cavaliere inesistente (1959). Viene pubblicato nel 1952 da Einaudi nella collana I gettoni su sollecitazione di Ellio Vittorini e raccoglie subito l’attenzione della critica.
Lo scopo della narrativa per Calvino era il medesimo che Brecht ha fissato in un suo «meraviglioso assioma» sul teatro: divertire la gente. Nelle pagine della trilogia si percepisce netta e prepotente questa voglia di raccontare, di stupire, di tornare alle origini e alle tradizioni della narrazione regionale italiana di cui è massimo esperto. Sono gli anni del lavoro d'indagine, antropologico e sociologico al tempo stesso, delle Fiabe italiane con la riscrittura parziale dei testi, un patrimonio che dall'oralità passa alla pagina scritta e che dall’oralità eredita tematiche eterne.
«Dell'uomo mutilato e alienato e della sua aspirazione all'interezza.»
Il romanzo affronta un problema essenziale della letteratura del momento: il problema dell’uomo, che ha perso la sua “interezza” e vive a “tronconi”, l’uomo scisso, incompleto. Cecchi ha ricordato un certo «gusto gotico» di Calvino.
Scrive Franco Antonicelli nel 1952 per La Stampa:
«Per questo pare proprio che Italo Calvino abbia scritto il suo ultimo racconto, o allegoria, quella del visconte di Terralba che andò in guerra contro i turchi al servizio dell'imperatore, e fu spezzato in due da una cannonata. Salvata e ricostituita alla meglio, una parte del visconte torna ai suoi domìni nel Genovesato, ma è la parte malvagia che vorrà tutto dimezzare a sua somiglianza, seminando lutti e terrori. Finché un giorno tornerà alla sua terra anche l'altra metà, la buona, che darà generose prove del suo animo. Sarà poi l'amore per una stessa rustica Pamela a fare scontrare l'una con l'altra e, miracolosamente, a ricongiungerle ricostruendo così l'antico visconte. Libera, sciolta fantasticheria; motivo esteriore di un balletto waltdisneysiano, ma con intimo sapore di causticità, d'intelligenza e di moralità settecentesche. […] Nessuno in Italia ha avuto finora la felicissima vena grottesca di Calvino. Ma qui m'importa rilevare la «moralità» dov'è dichiarata: “non basta un visconte completo perché diventi completo tutto il mondo”, oppure “alle volte uno si crede incompleto ed è soltanto giovane”.»
Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway
Come parlare dei romanzi del 1952 senza citare Il vecchio e il mare?
Vincitore del Premio Pulitzer nel 1953 è forse il romanzo più noto dell’autore americano, o per lo meno uno dei più importanti, espressamente citato nella motivazione del Premio Nobel nel 1954: For his mastery of the art of narrative, most recently demonstrated in The Old Man and the Sea, and for the influence that he has exerted on contemporary style.
Uscito in modo inusuale nel 1952 negli Stati Uniti - la rivista Life, con una iniziativa senza precedenti, l’aveva comprato e pubblicato interamente sul suo numero d'agosto - la critica lo accoglie con favore anche in Italia, tanto che in una prima segnalazione che anticipa l’uscita si legge «Hemingway il “vecchio campione”, ha scelto l'anno olimpico per riconquistarsi il titolo che aveva tante volte messo in gioco e che è stato sul punto di perdere. Il vecchio e il mare, nato in un momento di rara perfezione, è un trionfo personale, il trionfo dell'uomo sull'avversità.» Ma non è un coro unanime. Da subito raffrontato dalla critica al Moby Dick di Melville scrive - evidentemente un po’ troppo di getto – Arrigo Cajumi il 16 ottobre 1952:
«Uno strano racconto The old man and the sea. È molto probabile che i recensori inglesi abbiano tenuto presente nel verdetto Moby Dick, ben noto anche fra noi grazie alla traduzione di Cesare Pavese; e certo il poema marino di Melville è come l'Odissea al confronto di un en marge alla Jules Lemaître. Ma anche Il vegliardo e il mare, non mi induce a giudicare Hemingway uno scrittore “finito”. Nelle sue 127 pagine, ce ne sono cinquanta di troppo; però sappiamo che in Hemingway, l'avvio della narrazione è lento, faticoso, divagante. Il vecchio pescatore sfortunato, il ragazzino che lo ammira e lo rincuora, potevano—è vero — esser disegnati in pochi tratti; però le descrizioni, i dialoghi, lo squallore dell'età, l'incertezza del giornaliero sfamarsi, sono elementi del quadro.»
A compensare immediatamente ecco una splendida recensione di Giuseppe Prezzolini uscita il 7 novembre 1952:
«È scritto con la cura di un Flaubert. Son brevi frasi composte in generale di brevi parole, che si possono leggere ad alta voce con gioia d'orecchio. Hanno un ritmo paragonabile a quello d'un mare quieto, lungo una spiaggia. […] Questo libro è un portento, e non perde nulla paragonandolo a quello europeo, con il quale mi sembra essere in competizione. È un piccolo portento di prosa. Sarà un giorno usato nelle scuole. Non ci son parole superflue. Non c’è mai enfasi. Tutto è appropriato. Forse me lo rende ancora più, caro il contrasto con la prosa, spesse volte enfatica e aggrovigliata, di Faulkner. Mi piace che ci sia un libro che dimostra che si può scrivere oggi in un altro modo. Che si può scrivere senza ricerca di parole rare. Che basta saper usare quelle giuste, e metterle al posto dove vanno. E aver qualche cosa da dire... Due cose semplicissime, ma a quanto sembra, difficilissime.»
I racconti romani di Alberto Moravia
Dopo aver parlato de Il vecchio e il mare, torniamo in Italia con Moravia, che proprio di quel romanzo non fu critico entusiasta, tacciandolo di eccessivo estetismo. Parlare di Moravia significa entrare in quella diatriba politica e culturale che caratterizzò gli anni del secondo dopoguerra.
«Al confronto di Moravia, Maupassant è un sentimentalone.»
Di fatto la novità stava proprio nell’edizione antologica in due volumi che consentiva di concentrare sia la lettura sia la critica, quasi un sunto della sua scrittura. Da ricordare che sempre nel 1952 all’opera viene attribuito il Premio Strega, ma al contempo è inserita - il 2 aprile - nell’Indice dei libri proibiti (Index librorum prohibitorum) della Chiesa cattolica, insieme alle altre sue opere.
Arrigo Cajumi nel 1952 affrontava sulle pagine della Stampa queste tematiche partendo da due domande legate strettamente alla pubblicazione dei suoi racconti (ediz. Bompiani): perché hanno messo all’Indice i Racconti di Moravia? E perché i suoi lettori crescono continuamente di numero?
«Forse, gli autori dell'iscrizione delle opere di Moravia nell'Indice dei libri proibiti, hanno mirato a colpire un mondo letterario dal quale la divinità è assente, l'immagine di una società di indifferenti anche a quelli che sogliono chiamarsi i cattivi costumi, senza fede, senza speranza, senza carità. […] Nel repertorio di Moravia non ci sono personaggi simpatici: sono, in generale, dei falliti, dei maniaci, degli infelici che contaminano gli altri con la loro infelicità. Però — e qui è la forza dello scrittore — questa materia vile, questi personaggi meschini e antipatici, sono trattati con mano da maestro: una specie di congegno di orologeria mette in moto un meccanismo, e il lettore è preso nell'ingranaggio fino all'epilogo. I Racconti, ripresi e saggiati, mi hanno convinto che il miglior Moravia non è in Cortigiana stanca, né l’lnvemo di malato, novelle che vent'anni fa lo resero famoso, bensì nelle storie fin qui rimaste in secondo piano, come La provinciale e L'avaro, che mi paiono con l'Ufficiale Inglese e con Ritorno al mare, le gemme del libro. Nei racconti citati, l'uomo e la donna sono vivi e autentici, e lo senti.
I casi crudeli, gli episodi scabrosi, e soprattutto l'ingegnosità cronistica di Moravia, gli portan sempre nuovi lettori. Giacché il gusto di molti va a chi sa raccontar storie, a chi espone dei fatti, e se questi hanno del piccante e magari del frollo, i palati dei nostri contemporanei, avvezzi a salse pepate, son pronti a trangugiarli. Narratore esperto, Moravia non presenta rompicapi e svenevolezze stilistiche, scrive con le parole di tutti, non s'attarda in divagazioni, colloca immagini a spizzico per crear la atmosfera, senza dar loro troppa importanza, e distrarsi dal contar son affaire. Perché l'Indice se la sia presa, è spiegabile pensando che nessun insegnamento morale esce dalle sue pagine, mentre vengono accarezzati sentimenti, e dipinti spettacoli che non edificano (anzi offendono) il lettor cattolico. Dobbiamo ritenere che gli ecclesiastici censori abbian visto nell'arte di Moravia, un'arte galeotta, capace di affascinare le nuove generazioni, e tentino di sbarrarle la strada, senza considerare che il successo di molti libri dipende e discende dalla loro concordanza con i gusti e gli umori di chi li ricerca e li ama.»
La valle dell’Eden di John Steinbeck
Se oggi leggiamo questo titolo sicuramente il primo pensiero va a James Dean - straordinario interprete del tormentato protagonista Cal - al suo esordio come attore cinematografico per la regia di Elia Kazan. Ma siamo già nel 1955 e la storia precede il popolarissimo film ed è narrata nel romanzo omonimo del Premio Nobel John Steinbeck uscito nel 1952 e apparso in Italia per i tipi Mondadori nella prestigiosa collana Medusa nel 1954 nella traduzione di Giulio de Angelis (e subito ripubblicata nel 1955 nella collana I libri del pavone).
La Valle dell'Eden è la valle percorsa dal fiume Salinas, nella California settentrionale: un paesaggio noto ai lettori dello Steinbeck, indispensabile non solo come sfondo alla narrazione, ma come parte integrante di essa, e di cui non si può fare a meno se si vuol comprendere la psicologia dei personaggi e le loro reazioni agli avvenimenti. In questo scenario si colloca la vicenda di una famiglia patriarcale, con i suoi segreti e le difficili relazioni interpersonali che sfociano in un dramma che potremmo definire come la storia di Caino e Abele in California.
«Era naturale che, a un certo punto, esauriti forse i temi di carattere sociale del proprio mondo narrativo, lo Steinbeck ponesse la sua valle al centro stesso di una sua storia» si legge su La Stampa nel 1954 «una storia che risale alquanto nel tempo e ci riporta agli inizi della civilizzazione propriamente americana di quelle regioni, quando si costituiscono le famiglie, più o meno patriarcali, del tipo di quella da cui doveva poi nascere lo Steinbeck stesso. Cosi egli riprende qui la storia del suo paese e dei suoi bisnonni, con quel gusto per la terra natale e quella capacità di identificarsi con essa, che costituisce il pregio più autentico e duraturo delle sue opere migliori. In questo recente romanzo, la valle ed i suoi abitatori sono il tema fondamentale. Anzi, forse gli abitanti sono in certa guisa, accessori: il ritmo calmo delle giornate, il nome delle erbe e dei fiori, l'odore degli alberi e delle stagioni, i monti allegri ad oriente e quelli accigliati i ad occidente, il luccichio tranquillo o le improvvise furie devastatrici del fiume, sono i termini poetici, in senso costruttivo, del libro. Che è dunque, da questo punto di vista, un incantesimo della memoria. Non sono le disquisizioni e le tirate moraleggianti, che spesso appesantiscono trama del racconto, a dargli quel suo suono peculiare e genuino: piuttosto, è quel modo tipico dell'autore di guardare uomini e cose con semplice bonomia e fondamentale ottimismo. E in questo romanzo, che differisce alquanto dai suoi più noti e celebri, per l'abbandono di specifiche tesi sociali, e si riconnette invece a certe sue storie di tipo picaresco o alle novelle profumate di terra appena arata e di vento sulle colline, che sono senza dubbio le sue più riuscite anche se le meno ambiziose, ritroviamo appunto quelle sue qualità fondamentali, che rientrano nel grande filone whitmaniano della letteratura americana contemporanea.»
Il giudice e il suo boia di Friedrich Dürrenmatt
Indubbio e innegabile: Friedrich Dürrenmatt, svizzero di lingua tedesca, è stato uno dei maggiori drammaturghi del Novecento. Paragonato dalla critica a Ionesco o a Beckett soprattutto per la sostanza delle sue pièces “in cui assurdo e crudeltà vanno insieme ad un gusto sadico che fa della realtà un gioco patibolare”, ha sempre espresso in modo macroscopico, vistoso la sua attenzione per il dolore, il macabro, la morte. Ma oltre che al teatro Dùrrenmatt si è dedicato anche al romanzo e in particolare, di certo non casualmente, al romanzo giallo.
Il giudice e il suo boia – uscito in edizione originale nel 1952, ma tradotto e pubblicato in Italia nel 1960 da Feltrinelli nella collana Universale economica nella traduzione di Enrico Filippini - rientra in questo secondo filone creativo di come narrazione di genere. Come molte volte ricordato da chi ha analizzato le opere di Dürrenmatt, la sua scelta a favore di questo tipo di narrativa è legata all’interesse per il male e l'orrore. Un male e un orrore assoluti, che non prevedono vie d’uscita, “privi di una qualsiasi soluzione positiva sul piano della storia come su quello della metafisica”. Un romanzo, questo, che ha dato un nuovo passo al genere rendendo fluida l’immagine del colpevole e dell’innocente, in una trama seducente quanto inospitale.
«Il peccato originale sembra ancora dominare il mondo agli occhi di questo figlio di un pastore protestante – scrive Giorgio Manacorda nel 1972 vent’anni dopo la pubblicazione dell’opera in occasione della sua trasposizione televisiva -. Letterariamente Kafka e Brecht sembrano essere i due, apparentemente antinomici, poli fra cui si muove Dùrrenmatt. […] A Kafka (e a Poe) è da far risalire la tematica della colpevolezza assoluta e che informa di sé l'universo anche nelle sue manifestazioni più quotidiane, nonché il tema intimo e ricorrente della vittima che è anche carnefice, e viceversa del carnefice che è anche vittima. Cosa evidentissima nel Giudice e il suo boia in cui sia Bärlach che Tschanz sono contemporaneamente vittime ed assassini. Il primo perché è in qualche modo il mandante e il secondo l'esecutore. […] Col che il cerchio si chiude e il male seguita ad operare ineluttabilmente all'interno di una logica ferrea e sostanzialmente impenetrabile. La fiducia nella possibilità di modificare il reale è enunciata come speranza decaduta. Qualsiasi ipotesi palingenetica, sia che si basi sulla Bibbia o sul Capitale di Carlo Marx, è destinata a perire andando incontro o a “un capitalismo catastrofico” o ad una “catastrofe capitale”.»
Gli alunni del sole di Giuseppe Marotta
Chiudiamo con una velata critica all’offerta editoriale italiana. Questo piccolo capolavoro di Marotta è ora disponibile solo nel mercato dell’usato o in versione ebook. Non è più reperibile l’ultima edizione, Rizzoli, del 2004. Perché? Perché non rileggere quello che è il padre di quasi tutti i successivi romanzi su Napoli? Non dimentichiamo che parliamo del substrato su cui si sono formati – più o meno consapevolmente – autori come Domenico Starnone, Elena Ferrante, Antonella Cilento, Sorrentino e De Giovanni, tra gli altri. L’affresco di una Napoli che tenta di scrollarsi di dosso gli stereotipi e la retorica con un forte taglio umoristico e auto-ironico (ma quanto abbiamo bisogno di romanzi umoristici…! sono davvero pochi). Come non vedere il professor Bellavista di De Crescenzo nei tratti dell’ex-bidello di liceo Federico, che “a furia di bazzicare coi professori, si era fatto un curioso bagaglio di classica cultura” e questa cultura la dispensa a un gruppetto di amici, un ciabattino, un carbonaio, un barbiere, un fruttivendolo, un fattorino… sotto forma di iniziazione ai misteri della mitologia. Che cosa diventino, in bocca all'arguto napoletano le divinità elleniche è facile intuirlo e Marotta sa trarre gli effetti più umoristici dall’unione tra vernacolo e anacronismo, tra ingenuità apparente e malizia, così che don Saturno e donna Giunone, e persino il sommo padre degli dèi, o quelle “mezzecalzette che sarebbero gli eroi”, si presentano tutti quanti con un vivacissimo e spiritoso volto di macchiette napoletane. Ma non è macchiettistico il racconto, perché non si limita a questo: scende nel profondo nell’anima di una città dove gente sostanzialmente infelice, povera e a volte anche affamata, è capace di godere il raggio di sole che gioca con le ringhiere dei balconcini o del sapore di un acino di melagrana, e “di ragionare civilmente sulle verità antiche come il mondo, mescolando vita e mito, realtà e finzione, con sorridente saggezza e disinvoltura, da buoni alunni del sole”. Quando il povero ex-bidello muore nel suo sordido basso, non arriva dal cielo - come per Ercole – nessuna carrozza divina “a rapire nell'Olimpo il povero vecchietto stecchito” e il racconto si chiude tristemente, ma velocemente perché non è questo il tema dominante, ma lo è “il popolaresco e pagano culto del sole che non esclude affatto Ia cristiana accettazione dell'ombra”.
«Le pagine di Giuseppe Marotta scoppiettano – si legge su Stampa nel 1952 in un articolo a firma a.gr. -, si sfaccettano come per accogliere tutte le vibrazioni di colore dell'iride, palpitano di luce in ogni gradazione di intensità, si fanno di volta in volta tenere e malinconiche, saporose e piccanti, nostalgiche e realistica mente dolorose, rumorosa gioia, spassose e maliziose, ma sempre con un ritmo ben marcato, un segno netto e veloce, uno stile personale, insomma. Napoli, si capisce, è lo sfondo su cui i personaggi vivono la loro breve storia, uno sfondo però di massima importanza, che per lo più avanza con prepotenza in primo piano […] Napoli che diventa creatura umana, partecipe delle umane vicissitudini, casi tristi o lieti, pianti e risate, baruffe e paci, vita e il morte.»
Gli altri approfondimenti

La posta della redazione
Hai domande, dubbi, proposte? Vuoi uno spiegone? Scrivi alla redazione!
Per poter aggiungere un prodotto al carrello devi essere loggato con un profilo Feltrinelli.
Per poter aggiungere un prodotto alla lista dei desideri devi essere loggato con un profilo Feltrinelli.
Il Prodotto è stato aggiunto al carrello correttamente
Il Prodotto è stato aggiunto alla WishList correttamente